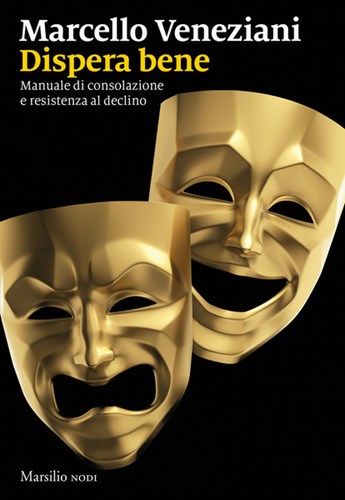
“Per cominciare, togliti di dosso questa maledizione: non vivi nel peggiore dei mondi possibili”. Questo scrive Marcello Veneziani nell’incipit del primo capitolo di Dispera bene. Manuale di consolazione e resistenza al declino (Marsilio, 2020). La tentazione, prosegue, di essere giunti al capolinea, alla consunzione definitiva è prassi antica ma “senile quanto puerile” in quanto nessuna prova incontrovertibile, nessuna evidenza inconfutabile di tale collasso finale possono darsi ma solo la consapevolezza, di chiara ascendenza, ma non solo, evoliana (e sul filosofo del tradizionalismo Veneziani si è esercitato negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso), che la storia dell’umanità sia marchiata da un “ciclo continuo di rinascite e decadenze, di fioriture e declini”. Certo, annota l’autore, se nelle epoche passate tali cicli avevano investito singole civiltà, oggi l’intera specie umana sembra minacciata dalle catastrofi demografica, ambientale e di una tecnica che, spezzata ogni catena ad opera della hybris, vomita “biomostri e tentazioni transumane”. Cionondimeno, suggerisce Veneziani, l’irrimediabile non ha forse ancora preso corpo e una “operosa” e “fattiva disperazione” è possibile, “capace di reagire pur senza farsi soverchie illusioni, in grado di camminare con perizia e attenzione sull’orlo dell’abisso senza cadervi”. Armati di questa, solo apparentemente ossimorica per l’autore, disperazione fiduciosa, proseguiamo nella lettura per assistere però, impotenti, pagina dopo pagina e tutte scritte peraltro con una assai ricca gamma cromatica, allo schianto della nostra fragile armatura sotto i colpi micidiali dei demoni e degli spiriti maligni che, attraversati tanto gli scritti filosofico-politici quanto quelli più sottilmente letterario-intimisti del nostro, sembrano qui essersi dati appuntamento.
Se, difatti, “flussi di allogeni del tutto stranieri alla civiltà in cui vengono a vivere” (che Veneziani è scettico circa la possibilità di facili e felici fecondazioni interculturali) e “mandrie di cittadini delocalizzati che abitano soltanto i loro tablet e smartphone”, addestrate da opinion maker e intellettuali à la page ad alimentare pulsioni ‘oicofobiche’ (disprezzanti cioè l’oikos, la propria casa), come ci ha avvertito il richiamato nel testo Roger Scruton, sono oramai il paesaggio prevalente dell’Occidente urbano, quale la via di fuga da tentare? Di più, se perlomeno dal 1968, annus horribilis par excellence per Veneziani, è andato smarrendosi il senso del limite e a questo smarrimento è andato aggiungendosi in anni più recenti il disgusto per qualsiasi aristocrazia culturale, se la cittadella europea è colpita all’esterno dal “fanatismo neo–islamico che viene dal sud” e al proprio interno dal “nichilismo libertario” dei Paesi protestanti prodighi di ritrovati autodistruttivi quali, solo per citare l’ultimo, il suicidio assistito, quale exit strategy percorrere? Si ha veramente l’impressione che, per l’intellettuale pugliese, non solo nel campo della politica, ridotta oramai ad “oltraggio sistematico alla verità e alla qualità”, l’unico rifugio, il solo buen retiro siano (e anche qui riaffiorano assonanze evoliane) “reti di affini, conventicole, cenacoli e comunità” coltivanti, quali neoordini monastici, il compito di “mettere in salvo il nucleo della civiltà decomposta e il genius loci, il filo reciso della tradizione”.
D’altronde, Veneziani, fin dalle pagine del Preludio, chiarisce che quello che squaderna al lettore è un “prontuario” con tanto di quadrifarmaco che si indirizza a quest’ultimo come singola persona, invitandolo a “farsi assente”, a ritirarsi insieme ai suoi pochi compagni di sventura, aderenti anche loro alla musiliana coscienza dell’inesistenza della felicità senza limiti e contrappesi, in fortilizi e nicchie impolitiche. Se così è, se non si intravedono punti di risalita, l’appello, contenuto nella Lettera a un ragazzo della classe duemila, penultimo capitolo del manuale, per una scuola che voglia “educare, lasciar traccia, trasmettere eredità, segnare limiti e confini” rischia di essere il messaggio in una bottiglia che un sempre minor numero di insegnanti capaci di sforzi sovrumani potrà raccogliere. Quanti, difatti, sarebbero disposti a fare propria “un’etica e un’estetica della disperazione” e la riscrittura della massima di Guglielmo il Taciturno, suggerita da Veneziani, e che suona: “occorre disperare per intraprendere e perseverare pur sapendo di non riuscire”? Non “dispera bene”, allora, potrebbe recitare il titolo delle prossime riedizioni, che auspichiamo; piuttosto “disperazione perfetta”, locuzione, d’altronde, proposta dallo stesso Veneziani.
Aggiornato il 25 febbraio 2020 alle ore 13:16


