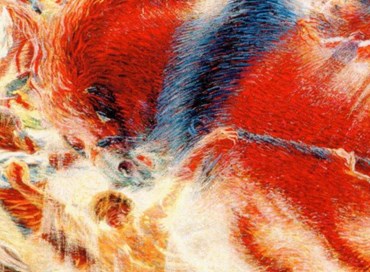
La decadenza o il fulgore di un paese hanno sempre molteplici cause, alcune principali e altre secondarie, ma certamente la dimensione culturale ha un influsso decisivo: tanto più il confronto delle idee è libero, non cioè ostacolato da prevaricazioni o da intimidazioni provenienti da una parte (non importa quale), tanto più la nazione intera sarà in ascesa, proprio perché assorbirà quella libertà diffusa. Che l’Italia stia vivendo una fase di decadenza è evidente da molti fattori, quello economico e quello politico in primo luogo, ma a certificare questo decadimento pluridecennale, certo con alcune oscillazioni che ne hanno ritardato il declino, è il degrado dell’atmosfera culturale, che vive sotto una cronicizzata minaccia da parte della sinistra, un atteggiamento intimidatorio rivolto verso chiunque abbia una visione diversa della società e della vita, verso quello che un tempo veniva esplicitamente chiamato il «nemico di classe» e che oggi viene sarcasticamente sbeffeggiato come buzzurro incolto o esponente di una sottocultura in quanto non portatore della cultura di sinistra.
Questo atteggiamento di alterigia ha permesso alla sinistra di costruire quell’egemonia culturale che i suoi maggiori teorici, Gramsci in testa, avevano individuato come il piano, parallelo a quello dell’economia, su cui esercitare la massima pressione, per una conquista che sarebbe stata più duratura rispetto alle inevitabili oscillazioni del piano economico. Nelle fabbriche e nelle piazze si riversava la potenza mobilitatrice e frontale della classe operaia, ma nelle aule scolastiche e universitarie, nelle redazioni dei giornali, nei teatri e negli ambienti cinematografici, nei circoli culturali, nei salotti, tanto più socialmente elevati tanto meglio, si dipanava l’azione di persuasione morbida per l’affermazione dell’ideologia comunista e del suo partito di riferimento, e una volta conquistati questi spazi veniva attuata una sistematica epurazione: noi dentro, voi fuori.
Questa egemonia culturale della sinistra è una realtà che stiamo subendo da più di mezzo secolo; è l’effetto del paziente lavoro di occupazione delle istituzioni e, come metodo, della pratica sistematica del disprezzo per gli avversari da parte degli intellettuali comunisti nelle loro varie sfumature, tranne rare e perciò lodevoli eccezioni rappresentate da alcune personalità eccellenti. Anche se gli «intellettuali organici» sono quasi scomparsi dallo scenario nazionale, sul piano culturale i nipotini di Gramsci e Togliatti non fanno concessioni, non arretrano nello spirito anche se, per svariate cause, hanno perso terreno rispetto ai fasti di qualche decennio fa. Consapevoli di ciò e consci dell’importanza della battaglia culturale, questi epigoni hanno conservato la medesima altezzosità che promanava dalle pagine di Rinascita: la cultura siamo noi, e voi non siete… nulla, per parafrasare il marchese del Grillo.
Che la questione dell’egemonia culturale non sia un tema storiografico ma un problema sempre attuale, lo ha mostrato Francesco Borgonovo in un articolo uscito su La Verità del 29 agosto, in cui viviseziona un lungo intervento di Gianrico Carofiglio, che su Repubblica aveva raccomandato l’uso della gentilezza come risposta alla presunta brutalità della destra. Spiega infatti Borgonovo che gli intellettuali di sinistra, di cui Carofiglio è un emblematico esponente, considerano con sdegno e sufficienza i loro interlocutori politicamente avversi, perché li ritengono violenti e ignoranti, e «perché cercano la zuffa, dicono balle e abbassano il livello culturale della nazione». E alla loro brutale incultura avrebbero deciso di opporre modi gentili, una variante salottiera del porgere l’altra guancia, senza però aver compreso che la loro storia, quella cioè del loro movimento politico-culturale, è una storia di violenza, di minacce, di sopraffazione e anche di crimini. Senza questo lavoro di autocomprensione storica, ogni ricorso a formalismi comportamentali e linguistici si rivela come un vano tentativo, in buona fede per alcuni di loro, in malafede per la maggior parte, di mantenere la rendita di posizione acquisita nel corso dei decenni. Infatti, conclude Borgonovo, «se avessero fatto i conti con la loro storia d’arroganza e presunzione, i progressisti capirebbero che, dall’altro lato della barricata, ci sono concittadini da rispettare, non bruti da insultare e svilire. O magari no, magari non cambieranno mai e rimarranno sempre così: serenamente stronzi». E anche gentilmente sadici (secondo sia la lettera sia lo spirito: nel loro pantheon, Sade ha un posto non trascurabile, sia pure eccentrico).
La gentilezza sembra essere dunque l’ultimo ritrovato della fucina culturale della sinistra italiana. Questi migliori (ovviamente nel senso togliattiano, non in quello platonico, che invece li smaschererebbe come sofisti, cioè come i peggiori) sono oggi anche gentili, bontà loro. Ora potremo godere anche della loro gentilezza, appunto octroyée, concessa dall’alto della loro migliorezza. Una gentilezza però tutta razionale, ricercata, forzata perché ritenuta utile, mentre chi è autenticamente gentile nemmeno si accorge di esserlo. Insomma: una gentilezza strumentale, ideologica. Già il fatto di pensare di usare la gentilezza, di costruire cioè uno scenario mentale in cui utilizzarla, contraddice l’essenza della gentilezza, che originariamente è pura spontaneità: natura e non cultura. La gentilezza, direbbe il parroco manzoniano, uno non se la può dare: ce l’ha o non ce l’ha, e la usa spontaneamente sempre e non solo quando ha deciso che, non importa per quale ragione, conviene.
Certo, le sue declinazioni a seconda dell’individuo e della sua acculturazione sono rilevanti, ma la sua essenza rimane tale e lo sguardo fenomenologico la coglie come tale. E’ vero che se la consideriamo come una prassi virtuosa o per meglio dire come un’apodosi della virtù, può essere insegnata, ma per questa via si arriverà all’ingentilimento, al galateo, non alla gentilezza autentica, a quella essenziale. Il citato Carofiglio che sembra fare della gentilezza il soft power del Ventunesimo secolo o Michele Serra che ne rivendica la primogenitura risalente a parecchi anni fa, la trattano infatti come uno strumento.
Invece il nodo della questione è lo strato ontologico della gentilezza: non come si è gentili ma dove lo si è, se cioè si è gentili sulla superficie del nostro agire, oppure nella profondità del nostro essere. Concesso che, ovviamente, vi sono molte forme dell’agire gentile e che quindi su questo piano si possono stabilire livelli e gradazioni della gentilezza, bisogna però anche ammettere che vi sono molti modi dell’essere gentile, non tutti immediatamente percepibili. Ma se non si opera la distinzione fra agire ed essere, non si riesce a comprendere l’essenza della gentilezza e quindi a vedere il nucleo teorico, psicologico e politico della questione: il compatimento che promana dai cosiddetti intellettuali di sinistra è insopportabile, un’autoattribuzione di superiorità di stampo sovietico, e infatti nella loro massima espressione di «liberalismo» essi arrivano alla sopportazione, a una malcelata tolleranza, tutt’al più, in rarissimi casi, alla condiscendenza. I loro atteggiamenti mostrano l’odio (di classe o di ideologia) nella variante del disprezzo culturale ammantato, così almeno dicono o vorrebbero, con modi gentili.
La psicologia dei gruppi non è solo una tecnica sperimentale ma, anche se i suoi praticanti spesso non lo sanno, ha un valore culturale filosofico e sociologico che ci permette di cogliere ciò che sta dietro (o sotto) alle espressioni linguistiche, cioè le loro motivazioni, inconsce o esplicite. Questa analisi, simile alla psicologia dei popoli, ha un risvolto che la trascende e la fa interagire con l’interpretazione fenomenologica (Husserl), la quale su un piano teoretico superiore porta all’evidenza l’essenza (l’eidos) delle cose e degli eventi, e quindi riesce a illuminare quelle zone oscure della mente e del linguaggio non con un metodo psicoanalitico ma con il metodo fenomenologico (che non è affatto una tecnica) della visione dell’essenza.
Se dunque l’oggetto di interpretazione è il terreno sottostante sia all’espressione linguistica sia alle operazioni psichiche stesse che si manifestano nell’intellighenzia di sinistra, allora il metodo fenomenologico ci consente di coglierne l’essenza in modo evidente e (sul piano fenomenico e logico) incontrovertibile. Ciò che appare come eidos di questo atteggiamento e di questo linguaggio è l’arroganza, la spocchia, quella supponenza che Vico chiamava la «boria dei dotti», quella vanagloria che la sinistra ha sempre praticato e profuso, spacciando l’etichetta per gentilezza, il buonismo per bontà, il liberazionismo per libertà, la decostruzione per verità.
Smascherati dunque gli inganni dialettici (che dal punto di vista del pensiero appaiono però come dislessici) di questi pontificatori del pressappoco e del quasi nulla, come fare dunque per soppiantarne quel potere socioculturale che ci appare sempre più come usurpato? Con un’operazione-verità (svelamento fenomenologico dell’essere delle cose), il cui programma è molto semplice: ripristinare i concetti e le categorie, riordinandoli non secondo convenienze ma secondo il loro essere; non confondere l’intuizione con l’erudizione, l’educazione (paideia, Bildung) con la demagogia, la realtà con la narrazione, l’identità (di genere o di popolo) con la fluidità, la libertà con il caos.
Iniziamo così ad esercitare la critica fenomenologica e ad assegnare noi i voti alla sinistra e ai suoi esponenti, prendendo le redini dei processi culturali, guidandoli e non subendoli, uscendo dall’angolo della presunta minorità in cui gli scaltri eredi di Gramsci e Sade hanno preteso di confinarci. Infatti, posto che bisogna distinguere i fenomeni culturali dai fenomeni da baraccone, questi ultimi vanno considerati e trattati come tali (con gentilezza se si è gentili, con altre forme se non si è gentili, ma questa diversità di azione, che per i sofisti-cati intellettuali della sinistra sembra decisiva, è un dettaglio rispetto alla verità delle cose, rispetto alla ricerca della verità nelle cose), mentre i fenomeni culturali vanno compresi, elaborati e governati, con l’autorevolezza che deriva non dalle forme ma dall’essenza del pensiero, dal cosa e non dal come.
Aggiornato il 09 settembre 2020 alle ore 10:58


