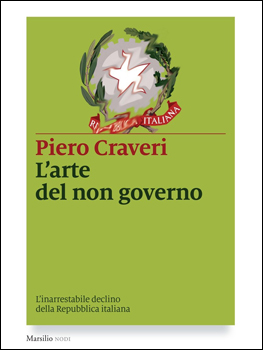
I governi che si sono susseguiti a partire dalla stagione del centrosinistra, inaugurata da Aldo Moro nel dicembre 1963, non hanno “avuto una coerente politica economica volta a sostenere lo sviluppo produttivo”.
Questa è la sentenza, impietosa, che Piero Craveri detta nel suo ultimo e ponderoso lavoro, L’arte del non governo. La profonda insufficienza culturale della classe politica nostrana, dopo l’età dell’oro del centrismo degasperiano, le avrebbe infatti impedito di possedere visioni di medio e lungo periodo. Così, alla crisi congiunturale del biennio 1963-64, che segnava una battuta d’arresto del miracolo economico del decennio precedente, i governi avrebbero risposto con maggiore spesa pubblica, utile anche negli anni successivi sia per arginare i primi conflitti sociali che per potenziare i consensi elettorali dei partiti che a quelle compagini partecipavano.
Il consolidamento di questi ultimi prese poi la forma negli anni Sessanta dell’estensione fanfaniana dell’area pubblica e parapubblica, della politicizzazione, complici i sindacati, degli apparati burocratici e dell’occupazione democristiana dei centri di erogazione della spesa e delle istituzioni cui avrebbe contribuito nel corso del decennio successivo il Pci. I comunisti, infatti, sebbene fuori dal governo, avrebbero iniziato a concorrere alle principali decisioni politiche e alla spartizione clientelare e consociativa delle risorse attraverso le “leggine”, approvate all’ombra delle Commissioni in sede legislativa e senza quindi il passaggio in aula. Non solo, la riforma negli anni Settanta dei regolamenti parlamentari indebolì l’Esecutivo di fronte al legislativo, dando nuova linfa alla democrazia assembleare e alimentando la crescita del debito. A quest’ultima dinamica diedero poi un contributo robusto la macroscopica irresponsabilità e demagogia delle centrali sindacali che nel biennio 1962-3, attraverso vertiginosi incrementi delle retribuzioni, fecero della pubblica amministrazione il serbatoio del loro consenso clientelare, concorrendo così al “progressivo sfascio di un sistema vitale come l’amministrazione per uno Stato democratico”.
La politica dei redditi, allora, che la Democrazia Cristiana non aveva mai avuto il coraggio di imporre al Pci, sarebbe stata perseguita da Bettino Craxi con il taglio di alcuni punti della scala mobile, gettando così alle ortiche un assioma della costituzione materiale, sacralizzato perlomeno fin dai tempi del centrosinistra, che voleva che la politica salariale avesse il beneplacito del Partito comunista. Craxi, però, non sarebbe riuscito a impedire la rovinosa esplosione del debito pubblico (e tantomeno a dare corpo alla solo ventilata “grande riforma” costituzionale).
Il bilancio della cosiddetta Seconda Repubblica tratteggiato da Craveri non è infine meno desolante: “La classe politica della Prima Repubblica porta la responsabilità della dimensione esorbitante del debito pubblico, quella della Seconda Repubblica invece quella di non aver fatto pressoché nulla per cercare di frenare il declino industriale e di porre le premesse di un suo rilancio”.
Tutto un altro spartito, invece, quello squadernato da Agostino Giovagnoli nel suo recentissimo La Repubblica degli italiani 1946-2016. Giovagnoli, allievo di Scoppola, di questi riprende ed enfatizza la valutazione nel complesso assai positiva del ruolo svolto dai partiti nell’immediato secondo dopoguerra. Più in generale, dal connubio di Cavour e Rattazzi al centrosinistra di Fanfani e Moro, passando per il centrismo degasperiano, le vicende nostrane prima e dopo l’Unità starebbero lì a dimostrare che i frutti migliori sono maturati quando è stato possibile raggiungere un accordo tra partiti. Quando così non è stato, si sono prodotti crisi e fratture esiziali, come nel primo dopoguerra, allorché la divisione tra popolari e socialisti avrebbe srotolato il tappeto rosso al fascismo trionfante. Certo, precisa Giovagnoli, anche le intese partitiche non sono tutte uguali. Non è così possibile mettere sullo stesso piano le “vere e proprie coalizioni politiche”, nate attorno ad obiettivi fortemente condivisivi, e le “semplici maggioranze parlamentari”, fragili e poco incisivi cartelli elettorali. Lo spartiacque tra queste due diverse realtà sarebbe stato il 1975.
Prima di quel turning-point, infatti, abbiamo, partorita dalla svolta di Salerno, la “democrazia consensuale”, intessuta, grazie all’accordo tra i partiti ciellenisti, di “un comune slancio ricostruttivo, positivamente diffuso in tutta la società italiana”, democrazia consensuale che caratterizzò gli anni della centralità democristiana e dell’incontro tra Dc e Psi.
Esauritosi il centrosinistra e con esso la “cultura della coalizione”, prese l’abbrivio, invece, secondo Giovagnoli, il tempo della “debolezza” di governo “che ha finito per logorare anche i patti fondamentali e le regole della convivenza”.
Tale processo degenerativo, manifestatosi pienamente negli anni del craxismo, avrebbe poi conosciuto la sua acme con la cosiddetta Seconda Repubblica, con il passaggio, complice la disintegrazione del partito cattolico, dal consensualismo al “bipolarismo conflittuale”. All’“inserimento degli eredi del Pci in un governo multipartito […] nella logica della democrazia consensuale”, si preferì realizzare, osserva cupo Giovagnoli, “l’alternanza di governo, sgombrando il campo dai partiti di centro e in particolare dalla Dc”.
Immaginiamo, allora, che l’amaro destino cui è andata incontro la proposta referendaria renziana possa, agli occhi dello storico cattolico, aprire orizzonti felici ed insperati, fatti di revival proporzionalistici, abbandono dell’odiato bipolarismo e radiose rinascite di coalizioni centriste.
(*) Professore associato in Storia Contemporanea - Università Roma Tre
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 22:43


