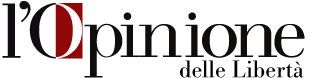Quando si affronta il rapporto fra Europa e mondo islamico, il dibattito contemporaneo tende a dividersi fra due estremi opposti. Da una parte vi è la visione universalista, che ritiene tutte le culture immediatamente compatibili e spiega ogni conflitto come semplice effetto della povertà o dell’esclusione sociale; dall’altra, c’è la tesi secondo cui l’Islam costituirebbe un sistema immutabile e naturalmente incompatibile con la modernità. Entrambe le posizioni semplificano una realtà molto più complessa. Le differenze oggi tanto visibili non nascono da una presunta essenza religiosa, ma da percorsi storici diversi. Esse sono il risultato di una divergenza di civiltà maturata nel corso di secoli, a partire da un’epoca in cui Cristianesimo e Islam erano molto più simili di quanto non siano oggi. Otto secoli fa, infatti, sia nel mondo cristiano sia in quello musulmano, la legge derivava da Dio, la società era teocentrica e l’idea di libertà individuale praticamente sconosciuta. Un giurista cristiano e un giudice musulmano del XIII secolo si sarebbero riconosciuti in un medesimo universo mentale: la legge morale e quella civile coincidevano, il peccato era anche un illecito, e la comunità valeva più del singolo. Anzi, in certi periodi la cultura islamica, con i suoi centri di studio a Cordova o a Baghdad, sotto il profilo filosofico e scientifico risultava più avanzata rispetto a quelle europea e cristiana. La distanza che oggi appare abissale allora non esisteva. Fu l’Europa, nei secoli successivi, a cambiare profondamente.
Fra il XIV e il XVIII secolo attraversò una lunga stagione di fratture e di rinascite: il Rinascimento riportò l’uomo al centro del mondo, la Riforma e le guerre di religione mostrarono che la fede non può essere imposta dallo Stato, la scienza moderna sostituì la verità rivelata con la verifica sperimentale, l’Illuminismo proclamò i diritti dell’individuo e la Rivoluzione francese affermò che la cittadinanza doveva essere indipendente dalla religione praticata. Da allora, il diritto europeo non nasce più da Dio, ma dall’uomo. La religione, da fonte del diritto, divenne libertà protetta dal diritto. Quella trasformazione, costata secoli di guerre e conflitti, fu la premessa della modernità occidentale. Nel mondo islamico, un processo analogo non si è compiuto. La Sharīʿa è rimasta, con gradi diversi di rigidità, la fonte primaria del diritto. Dove si è tentata una secolarizzazione, come in Turchia con Mustafa Kemal Atatürk (nella foto) o in Tunisia con Bourguiba, essa è stata imposta dall’alto e si è rivelata fragile. L’Islam non ha conosciuto una Riforma, un Illuminismo, né una rivoluzione dei diritti individuali. La legge divina continua a prevalere sulla legge civile, e l’idea di cittadinanza è ancora legata all’appartenenza religiosa. La modernità islamica, dunque, è incompiuta: non si è ancora prodotta la separazione fra religione e politica che in Europa ha trasformato la società. In questo contesto, la religione non solo orienta i comportamenti, ma definisce ciò che è reato. In molti Paesi islamici l’apostasia, la bestemmia, l’adulterio o l’omosessualità sono puniti penalmente non perché producano un danno sociale, ma perché violano un precetto divino. La religione non ispira la legge: è la legge. L’Europa, invece, ha percorso la direzione opposta: ciò che un tempo era peccato, come la blasfemia o l’adulterio, è stato progressivamente depenalizzato.
Per questo nei Paesi islamici la religione produce reati, mentre in Europa i reati derivano dalla violazione di diritti, non di dogmi. Quando individui provenienti da contesti teocratici si trasferiscono in società laiche e democratiche portano con sé un codice morale diverso. In molti casi, ciò che in Europa è un diritto, altrove è un delitto: la libertà di parola, la scelta sessuale, l’autonomia della donna, la critica religiosa. Questa diversa percezione del lecito e dell’illecito non scompare con l’immigrazione. Essa continua a orientare i comportamenti, a meno che non avvenga una vera trasformazione culturale, che è un processo lungo e complesso. Molti immigrati mantengono una doppia lealtà morale: rispettano le leggi europee per convenienza, ma giudicano la realtà secondo la morale religiosa d’origine. Da qui, nascono conflitti di valori, tensioni familiari e sociali, e comportamenti incompatibili con la legalità occidentale. Se questa era già da tempo messa in discussione da alcune componenti della tradizione del pensiero riconducibile al marxismo-leninismo, oggi molti cittadini occidentali e molti giovani che seguono o assecondano più o meno consapevolmente quella scuola di pensiero vedono nella cultura islamica un potenziale fattore rivoluzionario da sfruttare, se non da prendere come esempio. Ma questi non sono gli unici a vedere di buon occhio un’immigrazione islamica indiscriminata.
Molte altre persone, assolutamente in buona fede, auspicano una reale accoglienza e una vera integrazione, senza rendersi conto che i loro auspici si fondano spesso su l’illusione che basti includere economicamente e istruire linguisticamente per creare cittadini laici. Ma la modernità non è un insieme di regole trasferibili: è il risultato di un’evoluzione interiore durata secoli. L’Europa ha impiegato generazioni per separare la legge divina da quella civile e per sostituire la colpa morale con la responsabilità giuridica. Non si può pretendere che un immigrato, proveniente da una cultura dove la legge coincide con la volontà divina, assimili lo stesso paradigma in pochi anni, magari frequentando dei corsi serali. L’integrazione vera richiede una rielaborazione critica della propria tradizione e dei propri valori di riferimento, non una semplice adesione formale alle norme del Paese ospitante. E una tale rielaborazione non può avvenire che nel tempo, con un processo formativo che potrebbe rivelarsi tanto più efficace se affrontato frequentando scuole europee o comunque occidentali organizzate e gestite insieme ai Governi dei Paesi d’origine – almeno quando essi siano interessati a incoraggiare un processo di questo tipo – sui loro territori nazionali.
La frequentazione di tali scuole, supportata e finanziata anche dai Paesi occidentali destinati poi ad accogliere i giovani diplomati con regolare visto d’ingresso e viaggio aereo sicuro, potrebbe essere un modo efficace di garantire un’immigrazione in grado d’integrarsi e di contribuire poi a un maggiore benessere sia del Paese ospitante sia di quello di origine, e sicuramente più efficace e umano di un’accoglienza indiscriminata che mette a rischio la vita dei migranti per poi sfruttarli in modo non meno indiscriminato in lavori agricoli sottopagati, o lasciandogli gestire dalle mafie per lo spaccio di stupefacenti. Naturalmente, nessuno ha ancora mai avanzato una simile bozza di proposta, sia perché sarebbe controproducente per gli interessi di molti sia perché le statistiche ufficiali non aiutano a comprendere la dimensione culturale del problema, cui è purtroppo connessa una notevole propensione all’illegalità e alla violenza. Le istituzioni europee, per ragioni di privacy e di rispetto delle minoranze, preferiscono spesso non rilevare la religione degli autori dei reati in cui molti immigrati incorrono anche in mancanza di alternative in grado di garantire la loro sopravvivenza. Si raccolgono dati per cittadinanza, ma non per fede. Questo serve a evitare discriminazioni, ma priva la ricerca di uno strumento conoscitivo importante.
I dati disponibili mostrano, comunque, che alcune categorie d’immigrati, in particolare giovani uomini a basso reddito di religione islamica, sono sovra-rappresentati in quasi tutte le statistiche penali. Ciò non significa che la religione generi di per sé criminalità, ma che esistono condizioni di marginalità sociale e culturale più diffuse in certi gruppi. Quando si tengono costanti le variabili economiche e anagrafiche, la religione sembra perdere significato statistico, ma quelle stesse variabili sono a loro volta modellate da tradizioni religiose che hanno una marcata influenza sulla concezione della famiglia, sull’educazione e sul ruolo della donna. La religione, dunque, non è causa diretta di una propensione a commettere reati, ma è spesso una concausa profonda del contesto che la rende più probabile. La distanza che separa oggi l’Europa dal mondo islamico è quindi ad un tempo storica e culturale. Il cristianesimo, dopo secoli di scontri e di autocritica, si è trasformato in una cultura compatibile con la laicità e con il pluralismo; l’Islam, in larga parte, non ha ancora compiuto la stessa metamorfosi, e non sappiamo ancora se sia in grado di d’intraprenderla e se desideri farlo. Il conflitto contemporaneo non è comunque fra credenti e non credenti, ma fra due idee di legge: quella laica e riformabile dell’Occidente, e quella sacra e immutabile di molte società islamiche. La modernità europea non è nata da un decreto, ma da una lunga lotta dello spirito critico contro l’autorità religiosa.
È costata guerre, persecuzioni e rivoluzioni. Pretendere che un’altra civiltà attraversi lo stesso cammino in una o due generazioni è un errore di prospettiva. Le civiltà cambiano lentamente, e solo quando una crisi interna le costringe a ripensarsi. L’integrazione autentica non può essere conseguita con una serie di procedure burocratiche, ma solo attraverso la metamorfosi di un orizzonte culturale, e ogni metamorfosi richiede del tempo e la possibilità di partecipare a un libero confronto tra posizioni diverse. L’Europa si trova così davanti a un compito difficile e ricco d’insidie: quello di difendere i valori che ha conquistato nel corso di secoli senza rinunciare al livello di tolleranza che hanno saputo generare. Per riuscirci deve riconoscere la profondità del divario che separa due mondi una volta simili, ma cresciuti in direzioni opposte, e comprendere che la distanza fra le civiltà non si colma con la buona volontà o integrazioni frettolose, ma con la lenta costruzione di un terreno culturale comune. Solo allora, forse, l’incontro fra Occidente e mondo islamico potrà trasformarsi in una reale civile convivenza e non in una forzata coabitazione destinata un giorno a deflagrare.
Aggiornato il 04 novembre 2025 alle ore 10:40