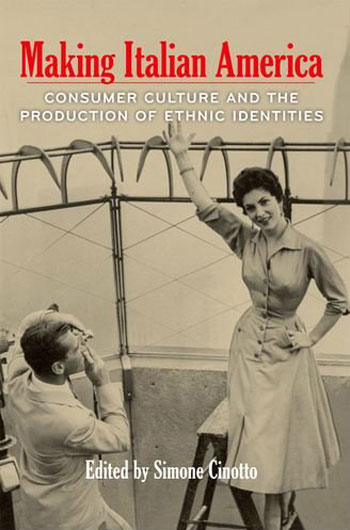
Abituati a studiare l’impatto che la società consumistica americana ebbe qui in Italia, è interessante capire come essa influenzò i nostri connazionali che emigrarono in America, e se e come essi abbiano a loro volta avuto un ruolo in essa. Per farlo, incontriamo il professor Simone Cinotto, autore di un interessantissimo volume che analizza e spiega con grande cura e competenza questo tema: un’altra delle tante diverse caratteristiche del rapporto tra Italia e Stati Uniti.
Professore, il suo ultimo libro si chiama “Making Italian America: Consumer Culture and the Production of Ethnic Identities”. Ce ne parla?
Nell’ambito dello studio dell’esperienza degli emigrati italiani negli Stati Uniti sono stati con successo affrontati i temi del loro approccio col mondo del lavoro, le loro comunità, le discriminazioni che vivevano, la dimensione religiosa, la famiglia, ma molto poco si trova invece circa la loro esperienza in qualità di consumatori. È un aspetto che io ho trovato invece molto importante, perché l’identità delle minoranze etniche si ricostruisce anche attraverso i prodotti che esse consumano, che rispecchiano il loro stile di vita. La cultura e la vita di questi italoamericani, sebbene all’inizio relativamente poveri e con un basso grado di educazione e dunque con pochi soldi da spendere, ha contagiato il mercato stesso, ritrovandosi nella moda, o nei film. È vero che diversi italiani, attraverso l’incontro col mercato americano, piano piano si assimilavano e si integravano, fino a concedersi il consumo di prodotti impensabili per loro in Italia; però, allo stesso tempo, essi non perdevano la loro identità italiana, anzi a volte ne acquistavano una maggiore consapevolezza e attaccamento. Mentre gli americani pensavano che gli spaghetti fossero il cibo più tipico che ogni italiano fosse abituato a consumare, molti di questi italiani emigrati imparavano proprio a New York come mangiare e dove trovare la pasta, attraverso un sistema di spedizione dall’Italia ovviamente creato appositamente per loro; mentre in Italia al di fuori di Napoli e l’Abruzzo la pasta intesa come prodotto industriale era in realtà a quei tempi un cibo molto raro. C’erano industrie in Italia create appositamente per produrre pasta, pomodori pelati e olio che sarebbero poi stati esportati per questi italiani all’estero: un vero e redditizio segmento di mercato. Nelle comunità si diffuse appunto l’idea di esprimere la loro italianità attraverso il consumo anche e soprattutto di prodotti italiani, sponsorizzati anche attraverso programmi radio prettamente dedicati alla cultura e al mondo italiano. Il consumo era quindi uno di quei processi attraverso cui gli Italiani in America costruivano la loro identità. Abbiamo dato anche una grande importanza al “processo transnazionale”, questa circolazione continua tra Italia e Stati Uniti non solo di capitali e prodotti ma anche di immagini e immaginario: nel tempo questo processo ha avuto intensità più o meno basse, ma è stato sempre presente. La storia del consumo del Novecento vista in chiave transatlantica tra Europa e Stati Uniti ha molto insistito sull’esportazione dagli Stati Uniti di modelli produttivi di marketing, pubbliche relazioni, fino in tempi più recenti all’idea del supermarket e poi del fast food. Quindi un processo da ovest verso est: l’Italia e l’Europa venivano “americanizzate”, soprattutto durante la guerra fredda, anche in chiave di strategia anticomunista, per imporre il consumismo americano. Il libro invece racconta di una circolazione del consumo anche in senso inverso, e dà l’idea di come sia vero anche che gli italiani abbiano “italianizzato” l’America.
È in programma l’uscita del suo libro nella versione in italiano?
Al momento no, purtroppo non è ancora in programma, ma valuterei volentieri proposte.
Le chiediamo un paio di esempi importanti per descrivere l’influenza che la società americana ebbe nel processo di integrazione e di cambiamento della comunità italiana – poi italoamericana – nel XX secolo, e lo stesso viceversa, come prima accennava. Quali sono i più importanti esempi di questa contaminazione?
Un approccio potrebbe essere quello della moda. Il primo capitolo del libro parla delle donne Italiane emigrate in America, in versione “produttrici di abiti Prêt-à-Porter” - invenzione prettamente americana riguardante vestiti fatti su scala di massa con costi molto ridotti rispetto alla sartoria tradizionale, che potevano quindi essere acquistati da un moltitudine di gente. Le donne italoamericane non trassero da questa innovazione solamente un modo di impegnare le proprie grandi capacità manuali, e quindi un’occupazione con relativo reddito, ma anche la possibilità di cambiare il proprio aspetto contribuendo anche qui a creare una definita identità etnica. Un altro capitolo parla invece dei vestiti da uomo: l’alta sartoria italiana - molti emigrati italiani erano sarti - trova appunto negli Stati Uniti la sua prima “vetrina ufficiale” come bene di qualità e di lusso, che non tutti possono permettersi. E’ la premessa al grande successo che in seguito i grandi stilisti italiani conseguiranno quando, grazie ad una grande strategia di marketing dell’industria italiana, i capi della moda italiana entreranno nel sistema della grande distribuzione americana, proprio come prima abbiamo visto per la pasta, l’olio e i pomodori pelati. Sicuramente la società americana ha dunque influenzato la comunità italoamericana inculcando l’idea del consumismo nella mente di italiani che in Italia non avevano disponibilità economica, e che quindi questo approccio proprio non lo conoscevano: a partire dalla banale acqua corrente, che per gli immigrati dal sud Italia era una novità. Molti degli ideali sociali che gli immigrati avevano erano di classico stampo contadino: il loro punto di partenza era l’idea di guadagnare, consumare molto poco e mandare il resto del denaro alla famiglia in Italia. Ma pian piano che gli anni passano e la loro integrazione aumenta, la loro identità denuncia un mix tra elementi americani e italiani. Ad esempio, mantengono vivo il desiderio sociale di diventare proprietari di casa (che è tipicamente italiano), mentre ad esempio gli immigrati ebrei continuavano a vivere in affitto investendo in altro. Negli anni Settanta-Ottanta del XX secolo anche per la cucina avviene una completa revisione dell’immaginario dell’Italia come luogo del buon gusto, e di ciò beneficeranno ovviamente sia gli italoamericani che tutto il sistema dell’export italiano. Era New York in particolare il luogo in cui tutti questi processi si incastravano, una continua interazione tra Italia e Stati Uniti.
Tra le aziende fondate dagli italoamericani ce ne sono di grande successo: ma poche, se non addirittura nessuna di esse, si sono particolarmente avvantaggiate o apertamente riferite, nel marketing, al fatto di essere anch’esse - in qualche modo - italiane: magari non “made in Italy”, ma “made in America by an Italian”. Sbagliamo? Lei che ne pensa?
Questo rapporto è stato storicamente complicato. Nella parte del libro dedicata al cibo si esaminano anche questi aspetti. Si pensi al dibattito sulle cosiddette indicazioni di origine su cui l’Unione Europea si arrabbia moltissimo, cercando di contrastare la falsificazione dei prodotti originali, specie in questi ultimi anni in cui il cibo è ormai concepito come sinonimo di cultura: in realtà si tratta di una cosa molto vecchia in campo italoamericano, che esisteva già nei primi anni del XX secolo. Il fascismo supportò grandemente l’export dall’Italia all’America, mentre – ad esempio – gli italoamericani che producevano il pomodoro in California mettevano in evidenza sull’etichetta la contadina italiana tra i campi col fazzoletto in testa, e approfittavano della loro italianità per vendere un prodotto creato negli Stati Uniti: con grande scorno dei produttori italiani, che pagavano tra l’altro significativi dazi per esportare il loro prodotto originale italiano in America. Non si parla solo di pomodoro: all’epoca si trovavano sugli scaffali americani cose come il “tonno Garibaldi”, le “acciughe Dante Alighieri”, tutti prodotti realizzati da italoamericani che chiaramente erano i precursori di quello che oggi viene chiamato “Italian sounding”. Per molti altri versi, invece, c’è stata una interazione, una collaborazione, tra Italiani ed Italoamericani. Si pensi a Lidia Bastianich, che tra l’altro arriva in America come profuga istriana. Lei ha iniziato a lavorare in un ristorante italoamericano, e solo successivamente è andata alla ricerca della cultura culinaria italiana (lei che aveva un profilo completamente diverso da quello del tipico maschio emigrato italiano meridionale), recuperando tutto un patrimonio di retaggio gastronomico e reinventando la cucina italiana in America, restituendole la giusta dimensione.
È indicativo che vengano in mente principalmente esempi sul cibo. Giusto?
Sull’italianità si costruì un vero e proprio business, sull’imprenditore in se per se, su quante volte tornava in Italia, su quanto potesse leggersi in lui la cultura e il modo di fare italiano. Magari non esiste il grande esempio della grande industria Italoamericana che si è avvalsa della propria italianità come risolutivo strumento di marketing, ma esistono diversi esempi minori in questo campo.
Nel dopoguerra la cultura consumistica americana entrò lentamente ma costantemente nelle case della penisola, rendendo felici milioni di italiani. Questa potente influenza fu percepita dagli italoamericani? E che ruolo ebbero, se ne ebbero uno, nella diffusione di questi contenuti e di questo stile di vita?
Quando dopo la guerra l’Italia è in bilico tra il campo atlantico, democratico e capitalista, e il comunismo, gli italoamericani si producono in un massivo invio di lettere e soldi ai loro parenti in Italia per spiegare loro quanto positivo sia il mondo del consumo in America, a cui si può auspicare scegliendo la democrazia. Tale gesto ha il fine di mostrare tutto il patriottismo degli italoamericani: le nuove generazioni apprezzano fortemente il consumismo e ne vedono gli aspetti positivi, e vogliono assolutamente che lo stesso possa essere disponibile per coloro che vivono nel loro Paese di origine.
Quindi questa presunta offensiva colonizzatrice consumistica, che un po’ in Italia è stata descritta come una sorta di invasione dall’America all’Italia, tra gli italoamericani non è stata percepita così?
No, affatto. Il sogno (italo)americano, che fosse comprarsi la casa o comprarsi la macchina, era il punto di realizzazione di tutti gli sforzi che gli immigrati avevano compiuto, vincendo le discriminazioni che li volevano diversi e impossibilitati ad integrarsi. Molti italoamericani hanno preferito godere di questo benessere che l’America offriva loro, e nel farlo non hanno mai immaginato che l’offerta di esportare questo modello anche in Italia potesse essere percepita come un qualcosa di sbagliato.
A proposito di consumismo e di modelli di approccio americani, ci incuriosisce la vicenda di Mike Bongiorno. Mentre in Italia i vantaggi della società dei consumi ed il suo principale artefice mediatico, la televisione, venivano di fatto incarnati da un italoamericano, negli Stati Uniti sembrava e sembra ancora oggi che quasi nessuno lo conoscesse. A suo avviso qual è il motivo di tutto ciò?
Non saprei dare una precisa motivazione, forse semplicemente non c’è. Mike Bongiorno ha impersonato in maniera straordinaria il concetto dell’esportazione del modello americano in Italia: ha preso il format televisivo americano, col suo tipico stile e linguaggio statunitense, e l’ha riproposto adattandolo ad un’Italia da esso profondamente diversa, ma in crescita, in movimento. È vero, è molto strano che questo fattore non sia stato conosciuto dagli italoamericani, che pure avrebbero potuto, se adeguatamente informati di questo fenomeno, ritrovare in lui un esempio e un personaggio dal quale sicuramente sentirsi rappresentati.
Aggiornato il 01 aprile 2017 alle ore 15:28


